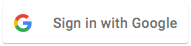Il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Martedì 09 Luglio 2019 16:05

Il Lambrusco è un vino rosso con caratteristiche tipiche del territorio di produzione: l'Emilia-Romagna.
Si tratta di un prodotto con acidità e tannicità contenute, vivace e gradevole, con una spuma leggera ed un aroma fruttato, il cui tasso alcolico è contenuto.
Per questo motivo il Lambrusco è un vino che si beve con facilità ed ha sempre rappresentato il simbolo tipico dei banchetti e della convivialità.
Caratteristiche del Lambrusco
Questo vino ha una tradizione antichissima risalente ai tempi dei romani quando la vite selvatica veniva denominata "labrusca".
I tipici vitigni del Lambrusco sono stati selezionati nei secoli da alcune famiglie del luogo che li hanno tramandati di generazione in generazione.
Pur vantando una lunghissima tradizione, il Lambrusco viene attualmente prodotto con tecniche all'avanguardia, che lo rendono uno dei vini più competitivi sul mercato, sia nazionale che internazionale.
Facente parte di una famiglia di vitigni autoctoni, cresciuti spontaneamente nella Pianura Padana, a tutt'oggi il Lambrusco viene prodotto in dodici differenti varietà.
I vitigni sono coltivati prevalentemente nei territori compresi tra Reggio Emilia e Modena, ed in minore percentuale nelle province di Parma e Mantova.
Le DOC modenesi più conosciute sono:
- Lambrusco di Sorbara
- Lambrusco Salamino di Santa Croce
- Lambrusco di Modena
- Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.
Caratteristiche del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Questo Lambrusco è un vino autoctono in quanto le sue uve provengono unicamente dal territorio modenese.
Possiede caratteristiche organolettiche difficilmente reperibili dato che è rosso e frizzante allo stesso tempo.
La coltivazione delle viti deve avvenire in pianura per assicurare una produzione con un moderato grado alcolico, considerato un punto a favore del vino.
La zona di produzione del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro si trova in provincia di Modena e comprende numerosi comuni, tra cui Sassuolo, Spilamberto, Vignola, Savignano sul Panaro, Maranello e Castelfranco Emilia.
Il suo nome deriva dalla particolare caratteristica del vitigno che in autunno presenta un arrossamento non soltanto delle foglie ma anche dei pedicelli e del raspo.
Sono disponibili quattro diverse tipologie e precisamente rosso spumante, rosso frizzante, rosato frizzante e rosato spumante.
Il rosso spumante e il rosso frizzante hanno un aspetto color rubino intenso mentre il rosato presenta una tonalità tendente all'arancione; l'aroma di tutte la tipologie è molto fine e gentile con un sentore floreale, vario e composito, unito a più intense note fruttate.
Il sapore del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro può essere secco o asciutto, semisecco o amabile, ma sempre di impronta fresca, armoniosa e con note dolci.
Il titolo alcolometrico è minimo di 11%Vol per la tipologia spumante, e di
10,50 %Vol per la tipologia frizzante.
Il suo grappolo è a forma conica, di lunghezza media, e presenta acini sferoidali dal colore blu intenso tendente al nero, con buccia molto consistente e polpa mediamente sugosa, con un retrogusto acidulo.
Viene coltivato su terreni asciutti di tipo collinare o sub collinare, poco permeabili e preferibilmente a componente argillosa, sabbiosa o marnosa.
Storia del Lambrusco di Grasparossa di Castelvetro
Questo vitigno ha una storia molto antica, infatti Catone nel suo trattato De Agricoltura, parla di una vitis labrusca che veniva coltivata ai suoi tempi per offrire una bevanda amabilmente frizzante durante i convivi.
Varrone nella sua opera De Rustica e lo storico Plinio in un volume della sua Historia Naturale, documentano ampiamente le caratteristiche del vitigno, esaltandone le qualità.
Anticamente il vitigno lambrusco era selvatico, derivante sia dalla vitis vinifera silvestris che da quella sativa, che nasceva spontaneamente come pianta infestante su terreni non coltivati.
In base a queste caratteristiche il lambrusco viene considerato il simbolo di uno dei vitigni più autoctoni del mondo, poiché derivante dall'evoluzione spontanea della vitis vinifera silvestris, le cui prime tracce si ricollegano al territorio modenese.
Nell'Ottocento anche altri autori confermarono la centralità del territorio di Modena per la coltivazione del vitigno del Lambrusco. Oggi tra i migliori produttori di questo incredibile vitgno ci sono l'Azienda San Paolo, Terraquilia, Antonio Aldini e Fangareggi.
Abbinamenti gastronomici del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Il presupposto fondamentale per degustare un Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di ottima qualità è quello di berlo entro i dodici mesi successivi alla vendemmia, poiché questo vino non deve essere invecchiato.
Di solito viene servito in calici allungati ad una temperatura compresa tra i dodici ed i quattordici gradi, per accompagnare numerosi cibi.
Grazie alle sue caratteristiche organolettiche, si abbina molto bene a piatti ricchi, di cui è in grado di esaltare i sapori, ed allo stesso tempo di facilitare la digestione.
Trattandosi di un prodotto tipico del modenese, questo lambrusco si sposa in maniera ideale a tutti gli insaccati, come prosciutto, salame, spalla cotta, e soprattutto culatello, del quale esalta la tipica sapidità.
Ottimo anche con formaggi a pasta fermentata o soggetti a lunga stagionatura.
È il compagno ideale per primi piatti come tortellini modenesi, tortelli di zucca, agnolotti e lasagne, anche se in alcuni casi si sposa benissimo con molti tipi di risotto, in particolare quello alla salsiccia.
In ambito di secondi piatti, questo lambrusco è abbinabile ad arrosti, cacciagione, e carne bollita, come il tipico "lesso" che fa parte della tipica tradizione gastronomica modenese.
Come fine pasto viene accostato alla ciambella reggiana, un dolce molto semplice ma gustoso; un altro abbinamento goloso è quello con gli zuccherini montanari.
La cantina
La cantina San Paolo affonda le sue radici nella tradizione emiliana, famosa per i suoi vini rifermentati naturalmente in bottiglia, da alcuni anni ha accostato l'innovazione alla tradizione, puntando sulla qualità e sulla preservazione del territorio.
Scopri di più